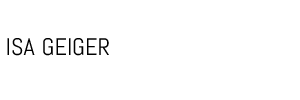The anti-Oedipus of sculpture
Gianluca Ranzi
One of the essential traits of sculpture appears to be its specific Oedipus complex. It is the original trauma linked to the maternal mass, which has to be “revealed” and formed: a mass that has to be raped, sculpted, cast, transported and erected; but it is also the trauma of the weight of the materials it is made from, clay, wood, plaster, stone, bronze, especially when it is associated with the idea of the death of sculpture, the assassination of the father who is killed because of his finiteness and unpredictable fragility.
It was necessary to account for and solve this many-sided Oedipus complex, in order for sculpture to recover its place in the contemporary debate on the visual art. For this to happen it has had to allow works within its magical circle which would never, until the late 19th century, have been included within this category. Indeed, it is precisely in that moment, paradoxically illuminated by a positivist faith in science and technology, that the humanitarian disciplines discovered the existence, beyond the Hercules’ Columns of their luminous field of research, of an unexplored submerged reality which it was due time to cast light on, an area of shade and irrationality which could no longer be omitted from an analysis and representation of reality.
The late 19th century saw the downfall of the myth of the totality which a certain interpretation of Greek philosophy and Christianity had elected as reason of the world: life, as Nietzsche writes in the Case of Wagner, no longer dwells in the totality, in an organic and finite Everything. This is when one begins to understand and to include, in the “great systems”, the link to irrationality and chance, to marginalities and lapses of intentionality, to the falsifiability of theories and the principle of indeterminateness, which if truth be told the Greek culture, as Eric Dodds has proven in his treatise The Greek and the Irrational never would have thought of eliminating from the constitutive foundations of reality, according to a concept where nature allocates life and death with absolute nonchalance, without any concern for the fate of individuals, who in fact are mere oί βρότoι or mortals.
This is how, in the tumultuous historical period of the late Nineteenth and early Twentieth century, literature, the visual arts, architecture, science, education, technology and philosophy discover that they no longer constitute the “totality” of things, but that they at most make up for nature’s indifference by venturing onto the very limits of what is humanly possible, in an attempt to go against nature. It is in that moment that the mirror-image of reality offered by art reveals, to the eyes of the “mortals”, the image of a disunited, heterogeneous, disjointed, fragmented and partial world without any solid foundations. And in the 20th century also sculpture becomes one of the symbolic places in which the “grand style” with its totality, accomplished and formed by tradition, dies.
Its position is overtaken by a dispersed reality of contemporary art, where sculpture is combined with the intangibility of the event (Ben Vautier and Piero Manzoni with their “Living sculptures”, Gina Pane and Marina Abramovic, performance and Body Art), with the transience of the rhythms of nature (Land Art and Giuliano Mauri’s marvellous poetic interpretation of “vegetal sculptures”), with Joseph Beuys’ idea of “social sculpture”, with the two-dimensional image of movies and videos (from Andy Warhol’s Empire to Bill Viola’s post-Renaissance tableaux vivant and, recently, to artists as Thomas Houseago), with the creative interdisciplinarity Olafur Eliasson, Jeun Choi and Björn Dahlem, who turn sculpture into a stage of action where botanicals, chemistry, physics and natural deterioration come into play, and finally with the anthropological gaze, intimist yet historical, of Danh Vo’s “shredded” sculptures.
It is against the background of this historical situation that contemporary sculptors, among whom Isabella Angelantoni Geiger and her work belongs with full rights, claim a personal right to a diaspora, to a mixing and contamination of disciplines, asserting an idea of the work of art which is less dependent upon space and volume, more and more insistently stressing the value of a time of action and comparison that is materialized in the form of the work, even when it is evanescent, gaseous and dematerialized, as in certain “sculptural” operations linked to sound, ideated by artists as Philip Glass, La Monte Young and more recently Susan Philipsz or Ei Arakawa. We are therefore dealing with a group of artists (who may also, with every reason, be seen in the light of the latest research fronts into theoretic physics, mathematics and philosophy) who proceed by small utopias and who allow for the fact that history cannot be controlled through their creative processes, and who once and for all forego the reassuring illusion of being part of a meaningful whole. The defeat of the Oedipus, of tradition and of limits that bring order and control and that used to provide reality a finite and stable form, is here accomplished through the production of works that represent – and this is also true of Angelantoni Geiger – precarious formal ventures that are never given a definitive manifestation, forms cum events associated with an ongoing process of construction and deconstruction that destabilizes certainties and gives rise to fertile cognitive anxieties.
The Anti-Oedipus is a theoretic and polemic work on the future of psychoanalysis written by Gilles Deleuze and Felix Guattari in 1969. According to the two authors, the Freudian denial of child sexuality on the one side assures control within the family and society, but on the other it lays a burden of guilt on a nomad and polymorph desire, impoverishing it and driving it towards forms of sexuality that are presentable and manageable in socioeconomical terms. The Anti-Oedipus thus intended to unveil the castrating mechanism of Freudian psychoanalysis, in order to free anarchical and socially subversive libidinous flows. In the same decade, more precisely in 1964, British art historian Herbert Read presented a theory on contemporary sculpture that in many aspects could remind of Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus. In fact, according to Read the evolution of sculpture in the 20th century, from Duchamp’s Ready-mades to assemblages and so on, have represented a liberation from the classical and academic tradition of the “full form”. This has entailed a certain lack of cohesion or definition, and a tendency to mix styles and new materials characterized by a lacking desire to give proof of any coherent stylistic and linguistic evolution. To Read new sculpture – and at this point it is evident that my thoughts go to Isabella Angelantoni Geiger’s structures in black metal wire – is therefore open as to form and free as to meaning, dynamic as to intentions and plastic as to disciplinary interferences; it has finally overcome the “Oedipal trauma of the mass” and therefore appears destructured, unbalanced in its relationship between masses and voids in favour of the latter, intangible and liberated from the rigid armour of a historical identity that blocks the flow of life, analogously to what Deleuze and Guattari have asserted in their book.
Isabella Angelantoni Geiger’s anti-Oedipal sculpture is therefore no longer cohesive in the sense of conforming to the rules of traditional sculpting of masses (by addition or subtraction). Instead it is cursive in the same way as a drawing that has become three-dimensional, a scribble in the air, fluid and emotional in a manner comparable to those rendered in such a masterly and magical manner by Erich Mendelsohn. This is why these sculptures, which do not feature any centre but are distributed in every direction, not disdaining the two-dimensional strategy of a drawing on a white surface, spread along the floor and walls, and into thin air. They no longer need a point of support or stability, but seem to elevate themselves from the ground, in an organic growth that reminds more of the world of plants and phytomorphic imagery than of the modus operandi of traditional sculpture. In other words, Angelantoni Geiger’s sculptures do without the ideals of spatial containment and ponderability, instead opening themselves to the possibilities of the flow of time, also when this requires them to make a curious reconsideration of the precariousness and instability of the work itself.
In this sense the works of Louise Nevelson, to which the works of artist have sometimes been likened, always presuppose a limited and closed space. If any element should cross this space, then it takes place with an infinite play with divisions into compartments within the works themselves. In the works of Isabella Angelantoni Geiger we are, on the contrary, dealing with an open drawing whose dematerialized, unstable and fragmented volume may develop in any direction. Its formal definition is almost graphic; even the shades projected on the wall become an essential and constitutive element. In her works space is not a matter of the geometry of Euclidean solids, but time renewed by a fractal proliferation of forms. Indeed, the iconic presence, here and there, of a Le Corbusier-inspired Modulor, a masculine and muscular humanoid, merely serves to underscore the untamed autonomy and anarchy of the black lines and the disorder of the whole within which that Modulor, who today appears somewhat chauvinistic, fumbles confusedly.
On the contrary, what takes form in the aleatory space of Isabella Angelantoni Geiger’s sculpture is another model, that does not use the structure as a load-bearing or tensive grid to support it, but which like a cobweb changes its form to accommodate for movements of the air, drops of dew that settle on it, the tiny movements and events of the day, in a never-ending multiplication and asymmetric proliferation of forms in the air. Consequently, if we were to look for a precedent, our thoughts would not go to projects such as Vladimir Tatlin’s Monument to the Third International from 1919, but rather to the contemporary works of Tadashi Kawamata, whose improbable shells made by small wooden sticks that cling to classical buildings and monuments (as for instance the one that perched on top of the Vendôme column in Paris in 2013) and his fascinatingly imprecise and poetic structures like the Collective Folie tower at the Parc de la Villette, also this in Paris and the Japanese artist’s homage to Swiss architect Bernard Tschumi’s Folies.
William Blake already spoke of a “fearful symmetry”, a symmetry that inspired awe and dismay, as well as of the connection between the idea of “left-overs” and “dissymmetry” in architecture and in the visual art. We may also mention the words of L. Donati, quoted by Bruno Zevi in Storia e controstoria dell’architettura in Italia, in the point where he asserts that: “Man is neither symmetric, nor self-sufficient, nor finite, and the environment created for him cannot contradict his innermost nature. Symmetry has always been the instrument of the few, used to oppress the many”.
In the final analysis, what takes form and acquires substance in the sculpture of the young Milanese artist is not so much a physical entity endowed with its own plastic manifestation, but rather an extension and a visualization of an imaginary horizon, an anarchic and dissymmetric “discard”. It is an artistic event inspired by the battle of the form, imprisoned in its shell, whose liberation in space becomes an echo of positive and negative, which fills the void with resounding vibrations.
L’anti-Edipo della scultura
Gianluca Ranzi
Connaturato alla scultura sembra essere anche il suo specifico complesso di Edipo. E’ il trauma originario legato alla massa materna da “svelare” e a cui dar forma: massa da violentare, da scolpire, da fondere, da trasportare e da erigere; ma è anche il trauma del peso dei suoi materiali, argilla, legno, gesso, pietra, bronzo, soprattutto quando associato all’idea della morte della scultura, dell’assassinio del padre che viene ucciso per la sua finitezza e la sua imprevedibile fragilità.
Era necessario fare i conti e risolvere questo sfaccettato complesso di Edipo perché la scultura rientrasse nel dibattito contemporaneo sulle arti visive e quindi accogliesse dentro il suo cerchio magico anche quanto, fino alla fine del XIX Secolo, sarebbe stato impensabile per quest’arte. Del resto è proprio in quel momento, paradossalmente illuminato dalla fede positivista nella scienza e nella tecnica, che le discipline umane scoprono che al di là delle colonne d’Ercole del loro luminoso periplo d’indagine, sta un sommerso inesplorato che è il momento di far emergere, una zona d’ombra e di irrazionalità che non può più venire espunta dall’analisi e dalla rappresentazione del quotidiano.
Alla fine del XIX Secolo crolla definitivamente quel mito della totalità che una certa interpretazione della filosofia greca e il Cristianesimo avevano eletto a ragione del mondo: la vita, come scrive Nietzsche nel Caso Wagner, non dimora più nella totalità, in un Tutto organico e concluso. E’ in quel momento infatti che si comincia a comprendere e a includere nei “grandi sistemi” il nesso con l’irrazionale e con il caso, con i margini del discorso e le cadute di intenzionalità, con la falsificabilità delle teorie e con il principio di indeterminazione, che a dir il vero la cultura greca, come ha poi dimostrato Eric Dodds nel suo saggio “I Greci e l’irrazionale”, mai aveva pensato di eliminare da sottofondo costitutivo della realtà, in una concezione per cui la natura distribuisce la vita e la morte con assoluta noncuranza, senza che vi sia nessuna partecipazione alla sorte degli individui, che sono infatti semplicemente “oί βρότoι”, i mortali.
Ecco che nella ribollente situazione storica della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento la letteratura, le arti visive, l’architettura, la scienza, l’educazione, la tecnica, la filosofia, scoprono di non comporre più la “totalità” della cosa, ma semmai di porre rimedio all’indifferenza della natura spingendosi fino a quel limite molto marginale che è dato all’uomo nel suo tentativo di contrastare la natura. E’ in quel momento che lo specchio della realtà offerto dall’arte svela agli occhi dei “mortali” un’immagine del mondo priva di unità, eterogenea, scomposta, frammentata, parziale e “campata in aria”, e anche la scultura nel corso del XX Secolo, diviene uno di quei luoghi simbolici in cui muore il “grande stile”, con la sua totalità piena e formata dalla tradizione.
Si afferma al suo posto quella dispersione contemporanea che ha frammisto la scultura con l’inafferrabilità dell’evento (Ben Vautier e Piero Manzoni con le loro “Sculture viventi”, Gina Pane e Marina Abramovic, la performance e la Body Art), con la transitorietà dei ritmi della natura (la Land art e quella meravigliosa declinazione poetica delle “sculture vegetali” di Giuliano Mauri), con l’idea di “scultura sociale” di Joseph Beuys, con l’immagine bidimensionale del film e del video (da Empire di Andy Warhol fino ai tableaux vivant post-rinascimentali di Bill Viola e, recentemente, ad artisti come Thomas Houseago), con l’interdisciplinarietà creativa di Olafur Eliasson, Jeun Choi e Björn Dahlem, che fanno della scultura un campo d’azione in cui entrano in gioco la botanica, la chimica, la fisica e il deperimento naturale o, infine, con lo sguardo antropologico, insieme intimista e storico, delle sculture “fatte a pezzi” di Danh Vo.
E’ da questa situazione storica che gli scultori contemporanei, tra cui in pieno si situa anche il lavoro di Isabella Angelantoni Geiger, rivendicano un loro personale diritto alla diaspora, all’attraversamento e alla contaminazione delle discipline, e affermano un’idea dell’opera che ha meno a che fare con lo spazio e il volume, mentre insiste sempre più sul valore di un tempo d’azione e di comparazione condensato nella forma dell’opera, anche quando essa è evanescente, gassosa e smaterializzata, come in certe operazioni “scultoree” legate al suono di artisti quali Philip Glass, La Monte Young e, più recentemente, Susan Philipsz o Ei Arakawa. Ecco dunque una compagine di artisti (che potremmo ben inquadrare anche alla luce dei più recenti orizzonti di ricerca della fisica teorica, della matematica e della filosofia) che procede per piccole utopie e che prende atto dell’impossibile controllo sulla storia attraverso il proprio processo creativo, rinunciando una volta per tutte all’illusione rasserenante di far parte di una totalità dotata di senso. Il superamento dell’Edipo, della tradizione e dei confini che conferivano ordine e controllo, e davano una forma conclusa e stabile alla realtà, qui avviene attraverso la produzione di opere che sono, come avviene per la Angelantoni Geiger, irruzioni formali precarie e mai formalizzate una volta per tutte, forme-evento legate a un processo continuo di costruire e de-costruire, che destabilizzano le certezze e introducono fertili inquietudini di conoscenza.
L’Anti-Edipo è un’opera teorica e polemica sul divenire della psicoanalisi scritta da Gilles Deleuze e Felix Guattari nel 1969. Per i due autori l’interdizione freudiana della sessualità infantile, mentre da una parte assicura il controllo familiare e poi quello sociale, dall’altra, colpevolizzando il desiderio nomade e polimorfo, lo depaupera schiacciandolo verso forme di sessualità rappresentabili e gestibili dal punto di vista dell’economia sociale. L’Anti-Edipo si proponeva pertanto di smascherare questo meccanismo castrante attuato dalla psicoanalisi freudiana, col fine di liberare i flussi libidici anarchici e socialmente eversivi. E’ sempre negli anni Sessanta, per la precisione nel 1964, che uno storico dell’arte inglese, Herbert Read, mette a punto una teoria sulla scultura contemporanea che per molti versi appare affine all’Anti-Edipo di Deleuze e Guattari. Secondo Read infatti l’evoluzione della scultura nel XX Secolo, dal Ready-made di Duchamp agli assemblages e via discorrendo, ha mostrato una liberazione dalla tradizione classica e accademica della “forma piena”, che ha di conseguenza comportato una certa mancanza di coesione o di definizione, verso una commistione di stili e di nuovi materiali priva del desiderio di mostrare un’evoluzione stilistica e linguistica coerente. Per Read la nuova scultura, ma a questo punto è evidente che il mio pensiero corra alle strutture in fil di ferro nero di Isabella Angelantoni Geiger, è quindi aperta nella forma e libera nei significati, dinamica nelle intenzioni e plastica nelle sue interferenze disciplinari, ha finalmente superato il “trauma edipico della massa” e si mostra di conseguenza sfratta, disequilibrata nel rapporto tra pieno e vuoto in favore di quest’ultimo, imponderabile e affrancata dalla rigida corazza di un’identità storica che blocca il fluire della vita, così come hanno parallelamente affermato anche Deleuze e Guattari nella loro opera.
Pertanto la scultura anti-edipica di Isabella Angelantoni Geiger non è più coesiva secondo i valori della massa (per addizione o sottrazione), ma è invece corsiva secondo le modalità di un disegno fattosi tridimensionale, uno scarabocchio nell’aria fluido ed emotivo, proprio come certi disegni di Erich Mendelsohn sanno magistralmente e magicamente esserlo. Ecco quindi che queste sculture, che non confermano un centro, ma si dispongono su ogni direttrice spaziale e adottano anche la strategia bidimensionale del disegno su una superficie bianca, vanno distribuendosi dal pavimento, alle pareti fino a galleggiare nell’aria. Esse non cercano più un punto d’appoggio o di stabilità, ma sembrano sollevarsi da terra e seguire una crescita organica più vicina al mondo delle piante e a un immaginario fitomorfico, piuttosto che alle ragioni intrinseche della scultura connesse con la sua tradizione. In altre parole le sculture della Angelantoni Geiger non si chiudono in un ideale di contenimento spaziale e di ponderabilità, ma si aprono all’eventualità del trascorrere del tempo, anche quando questo significa svolgere un curioso ripensamento sulla precarietà e sull’instabilità dell’opera stessa.
A questo proposito, se le opere di Louise Nevelson, a cui talvolta il lavoro dell’artista è stato accostato, presuppongono sempre uno spazio delimitato e chiuso, dove semmai l’attraversamento spaziale avviene nel gioco infinito della compartimentazione al loro interno, nelle opere di Isabella Angelantoni Geiger si è invece difronte a un disegno aperto di una volumetria scorporata che diviene instabile, frammentaria e imprevedibile nei suoi sviluppi generativi, con una definizione formale quasi grafica, di cui anche le ombre proiettate sul muro diventano una parte integrante e costitutiva. Lo spazio qui non è geometria di solidi euclidei, ma è tempo rinnovato dalla proliferazione frattalica delle forme, tanto che qui e là, la presenza ironica di un Modulor lecorbusieriano, esemplare maschile dai muscoli ben in vista, non fa altro che riaffermare la selvaggia autonomia e l’anarchia dei tratti neri e la disarticolazione di quella totalità entro cui quel Modulor, oggi un po’ sciovinista, annaspa disorientato.
Nello spazio aleatorio della scultura di Isabella Angelantoni Geiger prende invece forma un altro modello, che usa la struttura non come rete portante o tensiva al suo servizio, ma come una tela di ragno che rende conto anche dei movimenti dell’aria, delle gocce di rugiada che vi si depositano, dei minimi spostamenti e accadimenti del giorno, di una moltiplicazione incessante e di una proliferazione asimmetrica delle forme nell’aria. Per questa ragione se dovessimo ricercarne un precedente, l’attenzione non andrebbe tanto al progetto del Monumento alla Terza Internazionale di Vladimir Tatlin del 1919, quanto al lavoro odierno di Tadashi Kawamata, con i suoi improbabili bozzoli di assicelle di legno abbarbicati agli edifici classici e ai monumenti (ne è un esempio quello appollaiato sulla cima della Colonna Vendôme a Parigi nel 2013) e con le sue strutture felicemente imprecise e poetiche, come la torre Collective Folie al Parc de la Villette, sempre a Parigi, omaggio dell’artista giapponese alle Folies dell’architetto svizzero Bernard Tschumi.
Già William Blake parlava di una “fearful symmetry”, una simmetria che incute paura e sgomento, e del resto sul vincolo tra l’idea degli “scarti” e della “dissimmetria” in architettura e nelle arti visive, si possono anche ricordare le parole di L. Donati, riportate da Bruno Zevi in Storia e controstoria dell’architettura in Italia, quando afferma che: “L’uomo non è simmetrico, né autosufficiente, né finito, e l’ambiente creato per lui non può essere in contraddizione con la sua intima natura. La simmetria è sempre stato lo strumento dei pochi per sopraffare i molti”.
In definitiva nelle sculture della giovane artista milanese quello che prende corpo non è tanto un complesso fisico dotato di una sua propria manifestazione plastica, quanto è un’estensione e una visualizzazione di un orizzonte immaginario, uno “scarto” anarchico e dissimmetrico. E’ un fatto d’arte che nasce dalla lotta della forma imprigionata nel suo involucro e dalla cui liberazione lo spazio diventa un’eco di positivo e negativo, per cui anche il vuoto si fa pieno di risonanti vibrazioni.